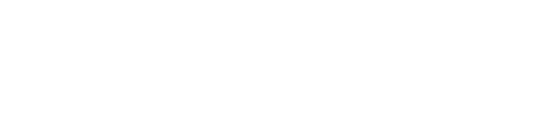Michelangelo Buonarroti. Il marmo, la luce, l’eterno.

Prof. Pasquale Lettieri
Critico d’arte Docente universitario
Ci sono artisti che scolpiscono la materia e
poi c’è Michelangelo, che scolpisce l’invisibile.
Non basta dire “scultore” o “pittore” per raccontare l’anima di Michelangelo Buonarroti (1475–1564), figlio inquieto del Rinascimento, spirito ribelle e profondamente cristiano, affamato d’assoluto, lui non ritrae ciò che vede cerca ciò che non si vede e nel farlo, lo libera. Come se la luce nel suo sguardo fosse una verità prigioniera dentro la pietra: il marmo non si crea, si scopre.
Michelangelo non considerava il marmo una materia da modellare, ma una creatura da svelare. “Non ho mai scolpito una statua”, diceva, “l’ho solo liberata”. Ogni sua opera nasce da un dialogo con la materia, come se l’anima del blocco già contenesse il volto, la carne, il tormento:
il David, la Pietà, gli Schiavi non finiti, sono battiti di luce incastrati nel marmo. Il martello non colpisce, interroga, lo scalpello non ferisce, accarezza, l’artista non impone ascolta.
La creazione, per lui, è un atto di liberazione, filosofica prima che artistica, mistica prima che estetica.





Una luce che viene da dentro che Michelangelo non usa per decorare.
La luce, per lui, è teologica, è epifania, è carne del Divino.
Nel Giudizio Universale, gli occhi non sanno dove fermarsi tutto è movimento, tutto è rivelazione, ma non c’è una luce “di scena”: la luminosità viene dalle figure stesse. Come se ognuna contenesse in sé la scintilla dell’eternità.
La sua pittura non cerca il bello, cerca il vero e il vero per lui è sempre inquieto, mai accomodante. I suoi personaggi sono muscolari non per estetica, ma per tensione, sono anime che combattono, salgono, lottano con Dio e con sé stesse.
Michelangelo è figlio del tempo in cui l’uomo torna al centro del mondo, è in realtà profondamente oltre il Rinascimento. Se da un lato abbraccia l’ideale umanista di un uomo potente, artefice del proprio destino, dall’altro ne denuncia i limiti, perché l’uomo da solo resta incompiuto.
La sua arte è sempre abitata da un’assenza una tensione verso Dio, verso l’infinito, verso una luce che non si lascia afferrare: è il grido di chi ha toccato la bellezza, ma sa che non basta. È la malinconia di chi intuisce il Paradiso ma abita l’incompiuto.
In questo senso, Michelangelo è profondamente filosofo la sua materia è ontologica, parla dell’essere, la carne scolpita non è mai solo carne è destino, è anima, è mistero.
Non tutti sanno che Michelangelo fu anche poeta e che nei suoi versi c’è la stessa forza della sua scultura parole spigolose, aspre, sincere. Scriveva in una lingua antica e visionaria, tra Dante e Petrarca, ma con la voce di un’anima tormentata e affamata di Dio.
In uno dei suoi sonetti più intensi dice:
“Non ha l’ottimo artista alcun concetto
ch’un marmo solo in sé non circoscriva
col suo soverchio; e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto”.
Parole che potrebbero valere anche per la vita.
C’è in noi un’opera nascosta, ma solo chi obbedisce al cuore e alla luce può liberarla.
Una ferita di bellezza
Michelangelo è stato, e resta, un’apertura nella storia dell’arte.
Un varco tra il tempo e l’eterno.
Le sue opere non sono mai “finite”, anche quando sono complete, sembrano ancora in atto di farsi, di nascere. Perché Michelangelo non vuole rassicurare vuole smuovere, non mostra l’ideale, ma lo scarto, la lotta, il grido, il brivido della creazione.
Il Rinascimento gli dà gli strumenti, ma non lo contiene, lui non è un artista del tempo è un uomo del destino, la sua arte non abbellisce, scuote.
Perché il marmo come la vita è già pieno di luce.
Serve solo il coraggio di tirarla fuori.
“Ex obscuro ad lucem”
(Dall’ombra alla luce)
Non è solo un motto.
È l’intera esistenza di Michelangelo.